Giuseppe Bonito, dopo L’Arminuta (2017) tratto dall’omonimo romanzo, torna sul grande schermo con Figli, uscito nelle sale il 23 gennaio.
Il lungometraggio affronta in modo leggero ed ironico l’essere genitori al giorno d’oggi, offrendo anche uno spaccato sociale e politico, che sottolinea la problematica de calo delle nascite, dovute alla precarietà lavorativa e alla mancanza di prospettive reali per il futuro di una coppia che decide di mettere al mondo una vita.

Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea
Figli: la trama
Nicola (Valerio Mastandrea) e Sara (Paola Cortellesi) hanno già una bambina, la loro vita procede tranquillamente tra i vari impegni lavorativi di entrambi finché non arriva la notizia di una seconda e inaspettata gravidanza.
La gestione familiare in teoria è divisa al 50 e 50 tra i due coniugi ma, come sempre, il carico mentale dell’organizzazione grava interamente sulle spalle di Sara. Con la nascita di Pietro le problematiche si acuiscono perché i genitori bis non riescono a farcela da soli, per la gestione del tempo e dei compiti da svolgere nella quotidianità lavorativa e familiare.
Cercando di trovare una soluzione, tra cartelle esattoriali e affitti da pagare, chiedono aiuto alle rispettive famiglie che appartengono a quell’epoca sessantottina che si è mangiata tutto quello che poteva, che godono di una pensione e che rappresentano la categoria degli ultimi privilegiati di quel sistema politico ed economico che, oggi, non garantisce neanche la metà di ciò che, in passato, è stato dato a loro.
L’unica soluzione che trovano idealmente Nicola e Sara, nei momenti più critici, è quella di scaraventarsi fuori dalla finestra della loro abitazione e di fuggire, cercando una quiete apparente.

Vario Mastandrea e Paola Cortellesi sono i protagonisti di Figli
Figli: lo spaccato sociale di oggi
Giuseppe Bonito, oltre a mettere in evidenza la criticità economica, politica e sociale del nostro tempo, si sofferma sull’individualismo e sul forte egoismo, che anima la maggior parte delle nostre scelte. Un esempio lampante è dato dalla scena in cui Nicola chiede aiuto a Cabo (Giorgio Barchiesi), suo padre, per aiutarlo a tenere il piccolo Pietro quando lui e Sara sono a lavoro.
Cabo, alla richiesta di aiuto familiare, risponde al figlio di non essere in grado di poterlo fare per mancanza di energie ma, subito dopo questa risposta, Nicola viene a sapere che Cabo sta cercando di diventare padre con la sua nuova compagna, molto più giovane di lui.
Figli è un film che lascia un sorriso amaro perché esasperando alcune situazioni, ci porta a riflettere sulla criticità sociale di oggi perché ciascun aspetto della nostra vita, anche quello più privato, è strettamente connesso a tutto ciò che ci gravita intorno anche se, apparentemente,la società ci sembra lontana dalla nostra quotidianità.
Paola Cortellesi, dopo Ma cosa ci dice il cervello, torna a farci sorridere con l’ironia che la contraddistingue infatti ne consigliamo vivamente la visione.
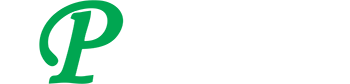











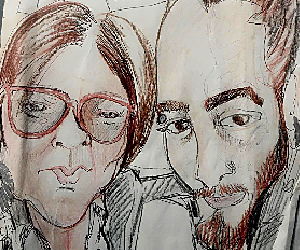
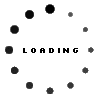
15 comments on Figli di Giuseppe Bonito: uno spaccato ironico sulla genitorialità di oggi
Comments are closed.